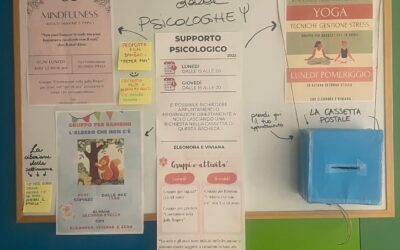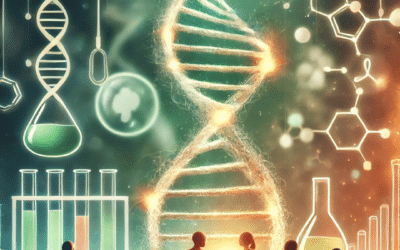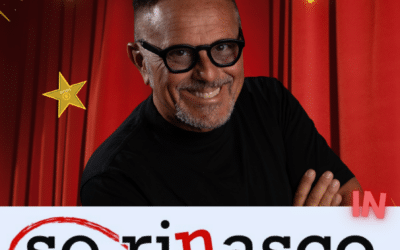I laboratori di tutto il mondo sono al lavoro per rendere sempre più precise le tecniche di imaging che permettano di scovare ovunque le cellule cancerose. I quattro principali istituti di ricerca e cura dei tumori lombardi sono in campo con uno straordinario progetto unitario finanziato dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (Airc) e voluto da Umberto Veronesi che ha come obiettivo l’esplorazione delle potenzialità delle tecniche di imaging unite alle più avanzate conoscenze genetiche, molecolari, farmacologiche e tecnologiche.
Sulle tracce del Dna.
Strumento raffinatissimo per osservare l’attività di un tumore è la Pet, che consente di studiare il metabolismo delle cellule misurando quanto esse utilizzano uno zucchero, cioè quanta energia consumano per crescere e proliferare. Ma non sempre lo zucchero è un buon marcatore, e Emilio Bombardieri, direttore della Struttura di Medicina nucleare dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano è partito dal presupposto che anche il materiale genetico coinvolto nella proliferazionesi possa dare informazioni, e ha cercato di fabbricare del Dna radioattivo. “Analizzando dove e in che misura è stato captato, si può avere un’idea precisa del tipo di attività cellulare in corso e quindi della presenza di un tumore attivo”, spiega Bombardieri. E si può capire anche se una terapia sta funzionando o meno. Entro fine anno dovrebbe iniziare uno studio pilota su una quindicina di donne con tumore al seno che devono sottoporsi a 5-6 cicli di chemioterapia per ridurre la massa prima di essere operate. L’idea è quella di controllare se la cura funziona, in modo da decidere se continuare la chemioterapia o interromperla per seguire altre strade.
A caccia di ossigeno.
Usa la Pet anche il lavoro in corso al San Raffaele. Spiega Maria Picchio, ricercatrice e group leader dell’Unità di ricerca: “Quando un tumore è in crescita al suo interno si formano zone con pochissimo ossigeno. Maggiore è l’ipossia più grave è la situazione e maggiori i rischi che il malato diventi presto resistente a chemio e radioterapia. Per questo stiamo cercando di mettere a punto un tipo di Pet che serva a quantificare specificamente l’ipossia”. Ecco allora che entra in scena un altro marcatore della Pet, una sostanza chiamata Faza che sembra avere caratteristiche ottimali. I primi dati ottenuti negli animali hanno avuto esito positivo.
Proteine radioattive.
I ricercatori del gruppo guidato da Giovanni Paganelli allo Ieo da anni stanno lavorando su tumori molto particolari: quelli neuroendocrini. Spiega Paganelli: “Questi tumori (in Italia se ne diagnosticano 2-3.000 all’anno), insorgono in molte zone dell’apparato digerente, nei polmoni e in altri tessuti; finora era molto difficile diagnosticarli perché si formano in più punti contemporaneamente, ma noi abbiamo dimostrato che se si usa la Pet con un tracciante marcato con Gallio 68 è possibile visualizzare molto bene la malattia e progettare quindi terapie più mirate”.
Ma non è tutto: la Pet classica non è utilizzata per la diagnosi di questi tumori perché solo un malato su due capta il glucosio e per gli altri il test è inutile. Paganelli e il suo gruppo hanno scoperto che il tumore che capta il glucosio è più maligno, risponde meno alla chemioterapia e va trattato in modo più aggressivo. E, spiega: “Abbiamo capito che coloro che hanno una malattia più aggressiva rispondono bene a una cura con peptidi marcati un altro isotopo, il lutezio 177, e abbiamo già trattato diversi pazienti, con risultati eccellenti, ancorché preliminari”.
Una mano alla difesa.
L’Istituto Humanitas usa l’imaging per studiare le relazioni che si instaurano tra cellule tumorali e sistema immunitario. Spiega Antonella Viola, coordinatrice del progetto: “I sistemi di imaging avanzato permettono oggi di osservare dal vivo ciò che un tempo era inosservabile, e di capire quindi molto meglio come è possibile intervenire quando un network biologico è alterato. In particolare, noi abbiamo scoperto che le cellule tumorali riescono a tenere lontani i linfociti T che si attivano per distruggerle modificando il microambiente che le circonda. E abbiamo identificato un farmaco sperimentale che sembra ripristinare le condizioni normali”.
Fonte: espresso.repubblica.it – 01 novembre 2011